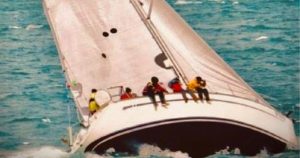La fiaccola
La fiaccola olimpica è un’icona-simbolo delle Olimpiadi moderne, riconosciuta dal Cio (Comitato internazionale olimpico) insieme alla bandiera, al motto e all’inno. Richiama l’immagine archetipica di un fuoco a cui si lega soprattutto l’idea di una lontana tradizione, la cui luce si riflette dal passato sul presente, messa in scena ogni quattro anni dalla staffetta della torcia.
“Questa spettacolare cerimonia sembra appagare un bisogno di ritualità, il bisogno di sentire che la modernizzazione non ha intaccato la continuità di certe tradizioni. Il problema è, però, che queste tradizioni, spesso percepite come un atavico retaggio, si rivelano a volte delle ‘invenzioni’ recenti”, spiega Daniele Demarco dell’Istituto di studi sul Mediterraneo (Ismed) del Cnr. “Come si possa ‘inventare’ una tradizione lo hanno spiegato bene gli storici Eric Hobsbawm e Terence Ranger. Altri studiosi, ad esempio Jan Assmann, hanno illustrato come alcune innovazioni possano essere innestate nella memoria storica. Nei secoli successivi a certi avvenimenti una narrazione si incarica di ripresentare i fatti e lo fa esaltando dati prima marginali o addirittura inesistenti. L’accettazione e l’iterazione del racconto fanno sì che esso sia accolto come autentico. La tradizione della staffetta della torcia olimpica nasce proprio in questo modo”.
Il fuoco sacro
Le antiche Olimpiadi infatti non onoravano questo rito: semplicemente, nel corso delle gare, si aveva cura di alimentare dei tripodi, i bracieri posti nei sacrari di Olimpia e, in particolare, all’interno del tempio di Zeus.
“Per i greci, come ricorda lo storico Jean-Pierre Vernant, il braciere simboleggiava il centro dello spazio. Associato alla dea Hestia, protettrice dei punti di riferimento immobili, esso indicava il centro della casa, il centro della città, il centro del mondo. L’accensione a Olimpia aveva, dunque, un senso molto chiaro: prescriveva che, per tutto il corso delle gare, il ‘centro’ della grecità fosse identificato in quella sede”, sottolinea il ricercatore del Cnr-Ismed.
L’era moderna
Quando, nel 1896, per iniziativa di Pierre de Coubertin, le antiche Olimpiadi furono ristabilite ad Atene, l’idea di far ardere di nuovo un tripode non entusiasmò più di tanto gli organizzatori.
Fino alla IX edizione (Amsterdam, 1928), non comparvero il braciere né la staffetta della fiaccola. “Fu solo per iniziativa dell’architetto Jan Wils, costruttore dello stadio dell’Olimpiade di Amsterdam, che il braciere irruppe nuovamente nelle Olimpiadi come elemento scenografico”, conclude Demarco. “La lunga staffetta con la torcia fu introdotta, poi, nell’XI Olimpiade, quella di Berlino del 1936. Tre anni prima la capitale tedesca aveva assistito all’ascesa al potere di Hitler, l’assegnazione dei giochi a Berlino fu un’occasione di propaganda per il nazismo, e il regime colse quest’opportunità per presentare la Germania come la nuova Grecia: l’erede, dunque, di una cultura antica da prendere in consegna e perpetuare. Joseph Goebbels e Carl Diem ebbero l’idea di inscenare questo passaggio di consegne: nel corso di un falso rito inaugurale orchestrato sulle rovine dell’antica Olimpia, alcune comparse travestite da sacerdotesse fecero brillare nuovamente un tripode. Poi la fiamma fu affidata a dei tedofori e questi furono incaricati di condurla a Berlino nel corso di una staffetta di 3.000 chilometri. L’intera cerimonia fu coordinata dalla regia di Leni Riefenstahl. Nonostante le critiche di chi vide in questa messa in scena la summa di tutte le parate naziste, l’iniziativa colpì de Coubertin, che si impegnò affinché il falso rito fosse stabilmente incorporato nel cerimoniale olimpico. La sua iniziativa ebbe successo. E così, da allora, la staffetta e la torcia sono divenute, in tutti sensi, una tradizione”.
La torcia di Fukushima
Una tradizione che si rinnoverà quest’anno con una torcia partita simbolicamente da Fukushima, nel periodo in cui trionfa la fioritura di ciliegi: lunga 71 cm e con un peso di 1,2 kg, spunterà da cinque petali, ricoperta in oro rosa per celebrare la natura floreale giapponese. Va ricordato poi che è stata realizzata in alluminio riciclato, ricavato dalle case provvisorie destinate agli sfollati dello Tsunami del 2011.
(Da CNR- Almanacco della Scienza n.13/2021)