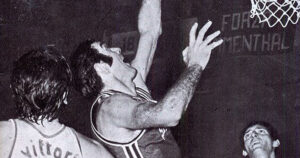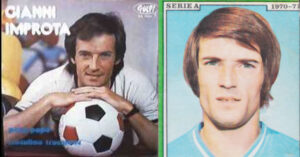Olga Biglieri. L’aerofuturista Barbara
Una vita di passioni. Il disegno, il brevetto di volo a vela a 18 anni, il mondo visto dall’alto. Olga Biglieri inizia a dipingere tutto quello che vede. L’incontro con il futurismo è dirompente, lei diventa Barbara e sarà la prima aeropittrice. Nel 1938 l’incontro casuale con Marinetti, poi le grandi mostre, poi la guerra che le fa cambiare strada, ma non il desiderio di vedere il mondo secondo il suo personale sguardo.